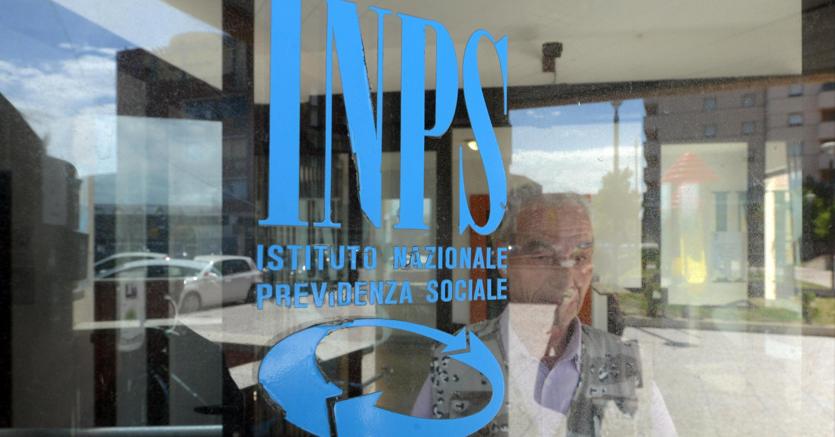Il Governo con la prossima legge di Bilancio deve bloccare l’attuale meccanismo di adeguamento dell’età della pensione di vecchiaia e anticipata all’aspettativa di vita. Lo chiedono, facendosi interpreti anche di sollecitazioni giunte dal mondo sindacale, Cesare Damiano (Pd) e Maurizio Sacconi (Epi), due ex ministri del Lavoro e attualmente presidenti, rispettivamente, delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.
In base agli scenari demografici Istat a gennaio 2019 l’età per la pensione di vecchiaia salirebbe da 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Poi si andrebbe a 67 anni e 3 mesi nel 2021, 68 anni e 1 mese nel 2031, 68 anni e 11 mesi nel 2041, 69 anni e 9 mesi nel 2051.
La proposta dei presidenti è invece per «un rinvio strutturale dell’adeguamento dell’età di pensione all’aspettativa di vita» spiega Damiano. Far scattare l’aumento sarebbe «inconcepibile», ha spiegato. La proposta è perciò inserire nella manovra, con la relativa copertura, una norma per allungare l’adeguamento (ad esempio a cinque anni contro gli attuali tre; due dal 2021) o evitare lo scatto nel 2019. «Siamo una strana coppia» ha scherzato Sacconi in conferenza stampa. «Abbiamo opinioni diverse per molte cose, ma questa situazione emergenziale ci ha spinto ad agire insieme per dire che quando è troppo è troppo» ha aggiunto il senatore che introdusse questo misura nel 2009. In Europa, hanno fatto notare Sacconi e Damiano, non ci sono casi comparabili a quello italiano: in Austria l’età per la pensione è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; in Belgio e in Danimarca è 65 anni per tutti; nel Regno Unito 65 anni (ma a partire da novembre 2018); in Germania si arriverà a 67 anni solo nel 2029.
Secondo Damiano, è necessario «affrontare tempestivamente in termini unitari questo argomento molto caldo, che riguarda la vita dei cittadini», anche perché «è estremamente contraddittorio» che si sia fatta una battaglia per la flessibilità con l’introduzione dell’Ape e insieme ci sia un innalzamento automatico dell’età della pensione: «È un andamento a zig zag inconcepibile». In passato si è parlato di «scale, scalini e scaloni – ha detto Sacconi – ma qui c’è solo un salto, che penalizza le donne più degli uomini, dal momento che sono condannate alla pensione di vecchiaia». Ieri intanto tecnici del Governo e sindacati si sono incontrati per proseguire il confronto previsto dal verbale d’intesa del settembre scorso sulla previdenza. Un vertice nel quale il Governo non ha preso posizione sulla questione posta da Damiano e Sacconi e che è servito per fare una ricognizione sui punti fissati nella “fase due” del verbale e che spaziano dalla pensione di garanzia contributiva per i giovani alle nuove regole da individuare per rendere più agevole l’accesso alla pensione complementare. L’impegno del governo è di garantire la piena applicazione delle misure previste nella “fase 1” del documento, con l’attuazione dell’Ape nelle sue tre forme (è atteso in settimana in parere del Consiglio di Stato sul Dpcm dell’Ape volontaria) mentre sulla “fase 2” per il momento non sono state presentate ipotesi di intervento già strutturate. Il governo starebbe studiando – stando a quanto è circolato dopo l’incontro – meccanismi per agevolare l’uscita delle donne attraverso l’Ape Sociale. Si potrebbero valutare “sconti” contributivi per le lavoratrici basati sui periodi di cura, assistenza e maternità, all’interno del meccanismo dell’anticipo pensionistico. L’obiettivo dell’operazione sarebbe quello di ridurre le disparità di genere sul fronte previdenziale.
Lo stop bipartisan alla pensione a 67 anni
L’adeguamento dei requisiti di pensionamento all’aspettativa di vita venne introdotto tra il 2009 e il 2010. Un principio di adeguatezza, si disse allora, e allo stesso tempo di stabilizzazione automatica di una spesa che andava (e va ancora) tenuta sotto stretto controllo.
Il meccanismo ha un carattere amministrativo, svincolato dalla politica, ed è stato praticato due volte finora: con un decreto del 2011, che ha elevato di tre mesi i requisiti nel triennio 2013-2015, e un decreto di fine 2016, che ha elevato nuovamente i requisiti di quattro mesi per il triennio che termina a fine 2018.
Ora la politica ha deciso di tirare il freno a mano con una mossa bipartisan firmata Sacconi e Damiano prima dello scatto atteso di cinque mesi e che, dal 2019, porterebbe l’età di pensionamento a 67 anni.
Le motivazioni avanzate dai presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato sono oggettive: nessun altro Paese dell’Eurozona ha raggiunto requisiti così elevati (in Germania i 67 anni scatterebbero nel 2029) e, in ogni caso, anche con un ripensamento di questo meccanismo, non si metterebbe in questione l’equilibrio interno del nostro sistema contributivo, che è garantito da un altro equilibratore: i coefficienti di trasformazione, ovvero gli algoritmi che si applicano per trasformare il montante contributivo in pensione, essi pure aggiornati ogni triennio (ogni due anni dal 2021) e a loro volta legati anche alle probabilità di sopravvivenza dopo la pensione.
Quello che la politica chiede oggi è quello che chiedono anche i sindacati: il governo ci ripensi con la prossima legge di Bilancio e individui le risorse necessarie per modificare il meccanismo. Una proposta evocata è di allungare gli intervalli di aggiornamento da tre a cinque anni, per esempio, utilizzando la stessa tempistica con cui il sistema di adeguamento delle pensioni alla speranza di vita scatterà in Spagna dall’anno prossimo. Si vedrà.
Non è la prima volta che la politica interviene per chiedere il disinnesco degli automatismi del nostro sistema previdenziale, quegli automatismi che ne garantiscono la sostenibilità finanziaria a discapito dell’adeguatezza delle pensioni future (soprattutto per i redditi bassi di chi ha avuto carriere molto discontinue). Nel 2014, al momento di effettuare l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione, quando ci si trovò di fronte a una variazione negativa della media quinquennale del Pil 2009-2013 pari a -0,1927% si decise (su proposta dell’Inps allora guidata dal commissario Tiziano Treu) d’introdurre una norma che stabiliva la “variazione zero” al posto dell’erosione del montante. E allora non arrivarono osservazioni critiche dagli osservatori internazionali, particolarmente attenti alla tenuta del sistema nel medio-lungo periodo.
Che cosa sarebbe successo invece con il pieno funzionamento dell’ascensore che eleva i requisiti in tandem con la speranza di vita ce lo ha ricordato qualche giorno fa l’Istat. L’età di vecchiaia salirebbe gradualmente di tre anni e due mesi nei prossimi 35 anni. Dai 66 anni e 7 mesi, in vigore per tutte le categorie di lavoratori fino a fine 2018, si arriverebbe a 69 anni e 9 mesi dal 2051.
Sono livelli sostenibili? Sì se il mercato del lavoro che sostiene il sistema previdenziale riesce a funzionare in modo tale da garantire carriere lunghe e continue ben oltre i 65 anni. Ma, appunto, quella è una base di partenza che oggi non abbiamo ancora e che va costruita mantenendo le flessibilità di uscita che sono coerenti con il sistema contributivo. L’anno prossimo, per esempio, scatta l’allineamento di tutti i requisiti di pensionamento (età e versamenti per l’uscita anticipata) di uomini e donne. Peccato che la posizione sul mercato del lavoro dei due sessi è alquanto differente: gli uomini hanno carriere contributive medie di 39 anni mentre le donne si fermano a 25 anni. Con il risultato che per le donne l’unica pensione possibile, per il momento, resta quella di vecchiaia. Modellare i meccamismi di adeguamento è dunque legittimo, a patto però di non far ripartire dinamiche di spesa che (se incontrollate) finirebbero per pesare sulle spalle delle generazioni che verranno.
Davide Colombo – Il Sole 24 Ore – 12 luglio 2017