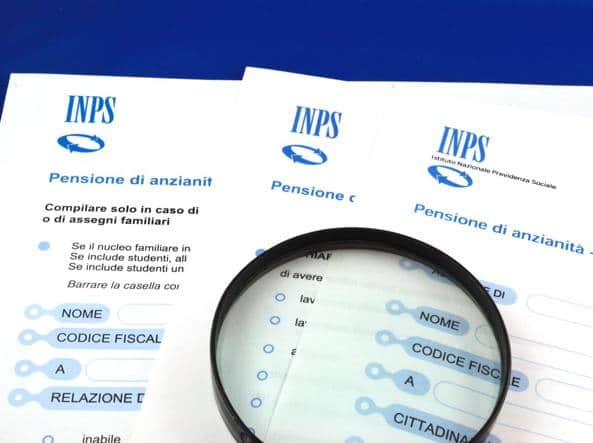E se le pensioni facessero la stessa fine dello ius soli? Nel governo cresce sempre di più la tentazione di rinviare a dopo le elezioni di primavera la decisione sull’aumento dell’età pensionabile, che nel 2019 dovrebbe salire di altri cinque mesi per arrivare a 67 anni tondi. Uno slittamento che farebbe il paio con quello già annunciato per la legge per rendere più facile l’acquisizione della cittadinanza italiana, sciopero della fame a staffetta permettendo. E che, in fondo, ne avrebbe la stessa ragione politica: schivare una decisione scomoda alla vigilia del voto per evitare ripercussioni nelle urne. Melina a centrocampo, deciderà il nuovo governo.
Il meccanismo previsto per legge
Sulle pensioni, però, non basta un annuncio in tv. L’adeguamento dell’età alla speranza di vita non è una scelta politica ma un atto previsto dalla legge. La revisione va fatta ogni tre anni sulla base dei dati Istat e il prossimo scalino è atteso per il 2019. In teoria c’è ancora tempo. Ma la decisione deve essere formalizzata entro fine novembre, cioè tra un meno di due mesi, con un decreto direttoriale, un atto del ministero del Lavoro che non passa in Parlamento. Rinviare è possibile. Ma solo a patto di avere una legge che lo preveda, magari sotto forma di emendamento parlamentare alla prossima legge di Bilancio. Altrimenti — come ha fatto sapere in via informale la Ragioneria generale dello Stato — i dirigenti chiamati a firmare il decreto potrebbero addirittura rischiare l’accusa di danno erariale. L’unica strada è una norma ponte che consenta di rinviare la decisione alla prossima primavera, quando saremmo ancora in tempo per definire la nuova età valida dal 2019 in poi.
La linea delle fermezza e la tentazione che sale
La linea ufficiale del governo è, e sarà ancora, quella della fermezza. Ma, dietro le dichiarazioni pubbliche, più o meno tutti i partiti si sono detti d’accordo sullo slittamento. La tregua armata eviterebbe battaglie su un tema difficile per tutti. Non è un caso che nei giorni caldi per il voto sul Def, Mdp — il partito nato dalla scissione a sinistra del Pd — non abbia puntato i piedi sulle pensioni concentrando le sue forze su altre questioni come il superticket. Non è un caso nemmeno che istituzioni come la Banca d’Italia o la Corte dei Conti abbiano fiutato l’aria di rinvio che si respira nei palazzi della politica. E siano passate al contrattacco, sottolineando più volte in questi giorni che un «arretramento» sul tema della previdenza metterebbe a rischio la tenuta dei conti pubblici. È vero che rinviare la decisione al dopo elezioni consentirebbe di intervenire in tempo per la scadenza fissata nel 2019. E avrebbe anche il vantaggio di lasciare in piedi tutte le ipotesi: un aumento a 67 anni per tutti; un aumento più contenuto (66 e 10 mesi) per tutti; uno stop all’aumento ma solo per chi svolge le cosiddette attività gravose, come le maestre d’asilo o gli infermieri. Non sarebbe per forza una marcia indietro. Ma, almeno a Bruxelles, sarebbe considerata senza dubbio una mossa preparatoria.
Il no di Padoan
Anche per questo nel governo c’è una voce nettamente contraria. E non è un dettaglio, perché è quella di Pier Carlo Padoan. Il ministro dell’Economia vuole che la scadenza del 30 novembre sia rispettata, come tutti i tecnici che lavorano sul tema. E non vuole «sconti» che potrebbero pesare sulle casse pubbliche e anche sull’eterna trattativa con Bruxelles, che tiene d’occhio il nostro deficit e il nostro debito pubblico. Ma a decidere, specie quando le urne si avvicinano, è sempre la politica. Padoan, pochi giorni fa, ha confermato che dopo la fine della legislatura lui in politica non ci sarà più. Un annuncio che forse lo rende più libero di dire quello che pensa davvero. Ma anche meno ascoltato da chi spera di esserci ancora.
Lorenzo Salvia – Il Corriere della Sera – 8 ottobre 2017