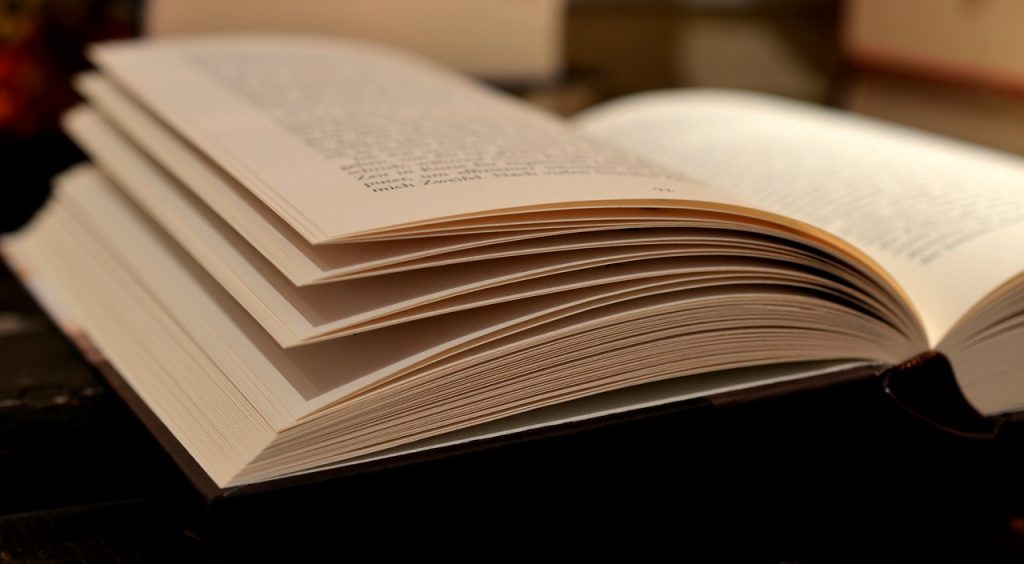Basta qualche dato per capire il problema. Il parametro di riferimento per misurare gli aumenti contrattuali dei dipendenti pubblici è l’Ipca, l’indice dei prezzi al consumo armonizzato. Nel 2021 era all’1,9%; il Def prevede per quest’anno un 5,8% destinato a scendere nei due anni successivi cumulando in ogni caso un +9,96% nell’arco del triennio.
Come si gestisce una corsa del genere? Per coprirla tutta, con una massa salariale che nella Pubblica amministrazione arriva intorno ai 187 miliardi incorporando l’effetto dei contratti 2019/21, bisognerebbe mettere sul tavolo della prossima tornata un valore complessivo da 18,6 miliardi. Quasi il triplo rispetto ai 6,8 miliardi in gioco nei negoziati sul 2019/21. L’Ipca che guida i contratti, è vero, è quello depurato dai prezzi dei beni energetici importati: e l’assunzione di questo criterio alleggerirebbe un po’ il carico. Ma non troppo, perché la fiammata dei prezzi energetici si trasmette nel tempo all’inflazione complessiva. Una conferma arriva ancora dal Def: nei tre anni il deflatore del Pil cumula una crescita del 7,27%. L’applicazione di questo parametro ai contratti pubblici richiederebbe 13,6 miliardi, il doppio dell’ultima tornata.
Queste poche cifre misurano bene la stazza dell’elefante che è destinato a occupare presto le sedi delle trattative fra governo e sindacati (non solo sul pubblico impiego). Perché la scelta è prima di tutto politica. L’Ipca, si diceva, è un parametro di riferimento, ma non è il Vangelo: i rinnovi in corso sul 2019/21 per esempio offrono aumenti medi pari a 2,3 volte l’indice del periodo, e lo stesso era accaduto sul 2016/18. Ora la necessità di gestire un’inflazione che ha abbandonato di botto il lungo sonno degli ultimi anni cambia radicalmente lo scenario.
Si spiega anche così la prudenza estrema con cui il Def tratta il tema. Nelle previsioni del conto economico delle Pa la spesa per i redditi da lavoro dipendente cresce quest’anno di 12 miliardi (da 176 a 188,8 miliardi); ma la spinta è data dalle intese 2019/21 destinate a farsi sentire nei prossimi mesi, poi la curva addirittura flette ai 187 miliardi del 2023 e ai 185,4 del 2024. Come mai? Perché, come spiega la nota metodologica (pagina 18) dove non è stato ancora deciso lo stanziamento le cifre tengono conto solo dell’indennità di vacanza contrattuale, la mini-voce (0,5% del tabellare) che entra in busta paga quando i contratti tardano.
Naturalmente non tutto il valore lordo dei rinnovi si traduce in un costo per la finanza pubblica. Perché il 37% abbondante dell’aumento nominale in busta paga torna immediatamente ai conti pubblici sotto forma di tasse e contributi (e come partita di giro nell’Irap pagata dalle Pa). E non tutto deve essere stanziato dalle leggi di bilancio, perché il 45% degli aumenti riguarda i dipendenti di Regioni, enti locali, sanità e università che devono finanziare gli stipendi con i propri bilanci autonomi. A patto di farcela, però: perché già il contratto 2019/21 mette in tensione i conti degli enti territoriali, chiamati anche alle assunzioni extra per l’attuazione del Pnrr. A misurare la «sostenibilità» delle spese di personale è il suo rapporto con le entrate. Che sono però rigide, con spazi fiscali già quasi completamente esauriti, mentre le uscite sono destinate a inevitabili aumenti periodici: in un equilibrio destinato a cedere presto.
Anche con queste accortezze, le cifre che si prospettano sono pesanti. E hanno portato il Mef a escluderle di fatto dai saldi di finanza pubblica (Sole 24 Ore di giovedì), con la promessa di trovare i fondi necessari grazie alle forbici della spending review; che però ha per ora obiettivi molto più modesti come si racconta nel servizio a pagina 8.